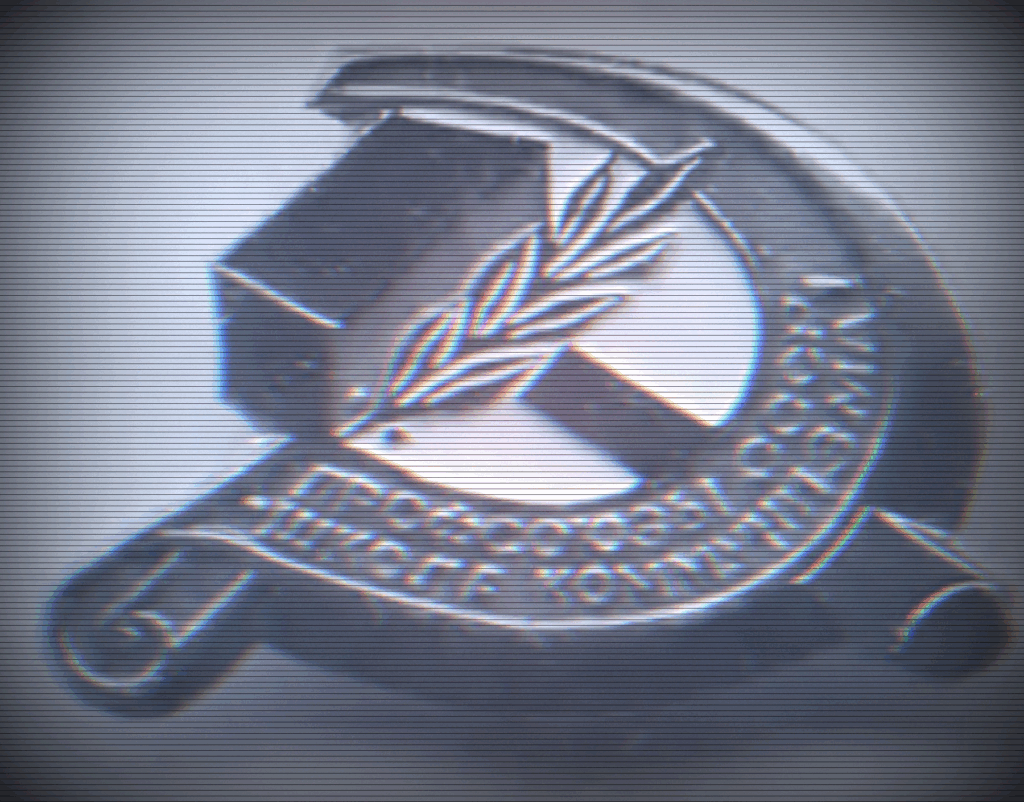
Di Paolo Selmi per sinistrainrete.info
I. Prima cosa: “Qual è il vero…”
Già nei primi anni del secolo emergeva, a livello organizzativo e ideologico, una nuova nozione, tipica di quel modo di intendere la lotta politica e sindacale, e che avrebbe accompagnato il giovane movimento rivoluzionario prima e l’intera vicenda sovietica poi: la partiticità (partijnost’, партийность).
Essa non riguardava soltanto l’orientamento e l’inquadramento dell’azione sindacale secondo quanto scritto da Lenin nel brano sopra riportato, ma anche l’influenza diretta che il POSDR avrebbe dovuto esercitare sul sindacato tramite i suoi iscritti, aventi anche tessera sindacale.
È quindi opportuno dedicare qualche breve cenno a tale concetto su cui – non da ultimo – si orienta ancora oggi la disciplina di partito nel Partito-Stato cinese: in base allo “spirito del partito” (lett. dang xing 党性), si misura tutto quanto avviene, giudicabile come fan dang (反党), “contro il partito” o wei dang (为党), “pro partito”.
Anche in questo caso, occorre partire dalle parole, prima ancora, dalle rappresentazioni ideali e dai significati che a tali parole sottendono. Anche perché con la “disciplina di partito” c’entra e non c’entra. Più “non c’entra” che “c’entra”, anzi, evocandola rischiamo di aumentare la confusione sotto il cielo, anche se in casi singoli poi si può tradurre tranquillamente con tale termine. In particolare, perché è un qualcosa che deve “partire” dal singolo iscritto, e non qualcosa a cui il singolo iscritto deve “attenersi”. Del resto, le differenze ci sono: altrimenti, Lenin sarebbe potuto essere tranquillamente stato uno dei nostri vicini di cortile, uscito fuori una mattina, magari dopo il primo quartino al bar per carburare bene la giornata, con la trovata che gli scrittori dovevan seguire la partijnost’… e noi avremmo trovato tutto normale. I processi nascono da lontano, e se nascono lì e non qui c’è un motivo, e non è solo un semplice rapporto economicistico causa-effetto: altrimenti noi saremmo ciò che mangiamo e, soprattutto, il pomeriggio saremmo tutti uniformati a quel che abbiam trovato in mensa in pausa pranzo.
A rendere inoltre necessario questo breve approfondimento resta il fatto che, come nella canzone di Jannacci (quella con “c’è sempre quello che parte…”), c’è sempre qualcuno che formula giudizi sull’operato altrui senza minimamente dubitare che il proprio ombelico possa, in qualche parte remota del globo, non essere esattamente il metro di giudizio con cui gli sfortunati indigeni di tali lande desolate pesano e formulano pensieri, parole, opere e omissioni.
Ecco allora che per una piena comprensione di quanto accade, in tali lande desolate, occorre identificare TUTTI i motivi per le scelte politiche, tattiche e strategiche operate in tali lande, e TUTTI i nessi a cui essa attiene. In quanto storici, sia pur militanti, abbiamo anche la fortuna peraltro di poter considerare “EX POST” i vari rimescolamenti di carte che ogni giocatore considerato nel nostro studio si trova IN QUEL PRECISO MOMENTO E LUOGO in mano, per giunta – come nel caso poc’anzi accennato della traduzione del marxismo in Estremo Oriente – senza sapere quanto realmente valga ciascuna delle carte che gli ha passato il mazziere, anzi, senza sapere neppure quante carte abbia in mano… e lasciandone pure qualcuna appiccicata dietro alle altre. Noi abbiamo la fortuna di leggere il tutto a giochi fatti. Un secolo e rotti dopo, in questo caso.
Vale la pena allora accennarne brevemente, a tali nessi, concentrandoci sul caso russo. Cominciamo con il sottolineare che, in Russia, non ci sarebbe stata partijnost’ senza un’idea particolare, tipicamente russa, di verità che loro chiamano pravda. Da noi europei occidentali la “verità”, l’essere “vero”, latino verus, evoca una lunga catena di rimandi, come nota giustamente l’Ernout Meillet1:

La radice originaria è quindi strettamente connessa all’atto del “credere”, che si conserva peraltro nello slavo vera, (cfr. russi вера, верить, radice tra l’altro inclusiva, come in italiano, del significato di “veri-ficare”, o proverit’ проверить). Dello stesso avviso è Max Vasmer2, che lavora molto sul collegamento fra il termine slavo e l’analogo antico germanico wâr. Il linguista “eretico” Semerano si spinge oltre, con incursioni nell’accadico e nell’ebraico, che ci portano alla rivelazione concessa al veggente dopo il rituale sacrificale3 e che, sostanzialmente, confermano da un’altra direzione l’impianto di fondo:

Comunque la si pensi, a prescindere da quale sia l’origine per cui si propenda, o da quali collegamenti e accostamenti si ritengano corretti, la sfera semantica del termine è abbastanza chiara; un po’ meno le implicazioni. Anche perché più si allarga il campo di ricerca, più aumentano le possibilità di incroci sulla nozione di “vero” e “verità” in altre culture, occidentali e non: a partire dal truth inglese al satya (सत्य) indiano, dalla aletheia (ἀλήθεια) greca alla ’emet (אמת) ebraica, da cui un certo ’āmēn tutt’ora in voga, il “vero” pronunciato ancora oggi dalle tre religioni rivelate (rispettivamente nella pronuncia ebraica e islamica, آمين; אמן ), fino alle molteplici sfumature di “vero” rappresentate da , zhēn 真, shì 是 , rán 然 e tutti gli altri segni impiegati nei millenni da cinesi, coreani, vietnamiti e giapponesi per meglio aderire a questa o quella specifica accezione; questo, ovviamente, al netto di tutte le altre migliaia di culture, scritte e orali, che mi piacerebbe anche solo conoscere e che invece ignoro, pur avendo popolato da millenni tutti i continenti del globo terrestre.
A ciascuno il suo “vero”, verrebbe da dire, con tutti i percorsi e contaminazioni, limiti e paletti spaziali e culturali, incontri e scontri che tale termine attraversa lungo la propria esistenza. Aver coscienza di questo, permette di concentrarsi sul nostro campo di esistenza, SENZA ALCUNA PRETESA DI ESSERE ESAUSTIVI.
II. Pravda: non solo “verità”. Significato e implicazioni storiche e ideologiche.
E nel nostro “campo di esistenza” considerato il primo termine che incontriamo è pravda: parola con una propria specificità che, proprio per l’importanza da essa ricoperta all’interno dell’architettura semantica della lingua e cultura russa, non solo quindi nella sua APPLICAZIONE IN CHIAVE RIVOLUZIONARIA, ha comportato ricadute, ripercussioni su altri termini e modi di vedere, ovvero ha consentito di decodificare e interpretare il reale da un’angolatura decisamente diversa da come avremmo potuto fare noi, in Occidente.
Il punto di partenza, in verità (mi si perdoni il gioco di parole), di originale ha ben poco. Pravda deriva infatti da *pravь, ovvero il “lato destro” di qualcosa, quindi ciò che è “giusto”, “autentico”, “vero”, “diritto” e “diretto”. La voce del Vasmer è un tripudio di analogie sia con le lingue del ceppo slavo, che con il latino probus e l’indiano antico prabhus, da cui l’inevitabile paragone con il termine latino prāvus immediatamente corrispondente4:

Troviamo quindi numerosissimi riscontri, in un condensato antropologico che meriterebbe da solo un’altra monografia. Se aggiungiamo poi la carrellata, la vagonata, di termini associati di “verità” nella storia dell’umanità, facciamo due monografie anziché due paragrafi: e non è il caso. Vi lascio alla stimolante e introduttiva lettura del classico di Mary Douglas su purezza e pericolo5, dove si tocca in molti punti l’infame destino storicamente toccato al lato sinistro, associato all’impuro e al pericoloso.
Ai fini del nostro lavoro, limitiamoci a considerare che non è assolutamente un caso il fatto che “lato destro” (droit, right, recht, derecha) vada poi a coincidere con “diritto” nel senso sia di direzione che di norma, quindi con “diritti”, quindi con “giusto” e giustizia, right ma non solo: oltre cortina il russo parte da “destra” (prava права), raggiunge il “diritto” (pravo право) toccando il “giusto” (pravil’nyj правильный), la giustizia (spravedlivost’ справедливость)…
…e arriva infine alla “verità” (pravda правда), passando per una serie di composti di significato affine (“aggiustare”, “verificare”, ecc.) resi in altre lingue con termini di radici diverse e qui, invece, sempre con la stessa radice *pravь.
Verità e giustizia in una sola parola! Questo è un tratto distintivo di una lingua tanto bella quanto scomoda, per chi occupa gli scranni più alti del potere.
Il primo a notarlo, nel 1889, fu il pubblicista, critico e divulgatore scientifico russo Nikolaj Konstantinovič Michajlovskij (1843–1904). Prima però di dargli voce, occorre introdurre un altro termine, usato dai russi per indicare quella verità intesa come “autenticità, perfetta rispondenza al principio di realtà”: senza andare troppo lontano, la rivelazione pentateucale “Io sono colui che sono, colui che è” (Es. 3,14; ehyeh ʾašer ʾehyeh אהיה אשר אהיה) riportata a principio di verità oggettiva. Questo termine è istina (истина).
Per noi neolatini è fin troppo semplice associare la radice *jьstъ al tempo presente, terza persona singolare del verbo latino essere, est (russo есть ancora usato oggi proprio per esprimere il principio di identità A=B) e all’aggettivo iste (codesto), come del resto fa il Vasmer6.
Diamo ora la parola al Michajlovskij:
Ogni volta che mi viene in mente la parola pravda, non posso non ammirare la sua dirompente bellezza interiore. Non esiste una parola simile, a mio avviso, in nessuna lingua europea. A me sembra che solo in russo verità autentica (istina истина) e giustizia (spravedlivost’ справедливость) siano racchiuse in una stessa, identica, parola e si fondano in un grande, intero, unicum. E così pravda, in questo enorme suo significato, ha sempre costituito l’obbiettivo delle mie ricerche7.
Notiamo subito una prima implicazione. La pravda russa si differenzia dal verum occidentale perché indica più un processo che un’istantanea (e qui fra ISTantanea e ISTina troviamo una radice comune!), una riproduzione statica del reale.
E SE “verità” è “giustizia”, ALLORA in un mondo ingiusto la verità si costruisce giorno per giorno.
E la LOTTA per la giustizia è LOTTA per la verità.
Seconda implicazione: tale PROCESSO, tale costruzione del “vero” e “giusto” non può che avvenire IN MANIERA PROCESSUALE ed essere DI MASSA, ovvero DAL BASSO: è la “base” del partito, del sindacato, a costruire ogni giorno questo percorso di giustizia e verità che non è solo costruzione di senso, ma realizzazione pratica, concreta, dello stesso.
Allo stesso modo in cui le rivolte contadine del feudalesimo russo di cui si è riportato poche pagine fa, “kak umeli i kak mogli”, cercavano verità e giustizia praticandola ogni giorno e rischiando le lance e le pallottole zariste.
Terza implicazione, che discende dalla seconda ma che è giusto sottolineare: la pravda calata dall’alto non esiste: è proprio la forza dirompente insita in tale visione a dimostrare che “il re è nudo”, ovvero a mettere a nudo qualsiasi menzogna. Per inciso, questo valse non solo per zar, boiardi e gerarchie ecclesiastiche ma anche, sempre per restare in tema, nell’ultimo decennio di URSS: “Nella Pravda (giornale) non c’è pravda (verità В Правде нет правды)”, era l’incipit di un aforisma molto popolare allora.
Quarta implicazione, anch’essa derivazione delle precedenti: la pravda in quanto verità è potente fonte di autolegittimazione per le pratiche di giustizia operate in suo nome. Inutile sottolineare quanto possa essere forte tale strumento nelle mani delle classi oppresse e quanto lo stesso fosse temuto da chi le opprimeva.
Quinta implicazione: la pravda come PROCESSO di COSTRUZIONE DI VERITÀ E GIUSTIZIA è necessariamente un movimento parziale, un’imperativo categorico, un atto soggettivo di UNA PARTE, O PARTITO, nella SUA lotta contro l’ingiustizia (e le menzogne). C’è sempre un’altra parte, o partito, che combatte tale processo, o lo guarda con indifferenza.
Sesto implicazione: la pravda così intesa non scade, non può scadere nel fanatismo, proprio perché LA RICERCA IMPLICA METODO, CHE È AL CONTEMPO SIA RIGORE CHE SENSIBILITÀ VERSO OGNI MUTAMENTO FRA LA FOTOGRAFIA DELL’OGGI, LA “ISTINA ATTUALE”, E QUELLA DEL FUTURO, LA “ISTINA DEL DOMANI”, guidati da una TENSIONE ETICO-MORALE FORTISSIMA, QUELLA VERSO LA GIUSTIZIA, CHE È METODO E, AL CONTEMPO, RISULTATO DA RAGGIUNGERE E INCORPORARE NELLA “ISTINA DEL DOMANI”. La verità pravda allora DIVIENE LA PUNTA PIÙ ALTA DI PASSIONE CIVILE, nel fotografare l’oggi, nell’immaginare un domani MIGLIORE, SENZA LE INGIUSTIZIE che attanagliano la fotografia dell’oggi, nel LOTTARE, concretamente, perché ciò avvenga, nel CONTROLLARE, passo dopo passo, se è avvenuto o no, ANALIZZANDO i motivi e le conseguenze di eventuali errori e, se necessario, LEGGENDO DIVERSAMENTE la fotografia dell’oggi e FACENDO MARCIA INDIETRO. La pravda non fa sconti a nessuno.
Settima implicazione: la pravda così intesa è l’antitesi del fatalismo, del determinismo, da un lato, ma anche del volontarismo e del velleitarismo dall’altro. Tutto dipende da noi, ma non sempre volere è potere. Anzi. STA ALLA NOSTRA INTELLIGENZA, AL NOSTRO INTEL-LIGERE, lavorare perché “la fede che ci accompagna” sia “la legge dell’avvenir” (Dalle belle città) attraverso passi concreti, non più lunghi della gamba che la pravda ci sbatte sempre davanti, perché è verità. Anche quando fa male. Prendete questa nozione, ora, e associatela al materialismo storico, insieme a un grande della Storia come Lenin. E si capiscono molte cose.
Solo suggestione? Il “rinnegato Epštein” (Michail Naumovič, 1950 – )8 uno dei tanti componenti la cosiddetta intellighenzia negli ultimi decenni di vita dell’URSS che, senza neanche attendere le esequie di chi li aveva lautamente stipendiati fino ad allora, dal calduccio della sua nuova residenza americana scriveva in uno dei suoi atti di fede, pardon, saggi iniziali (ancora in russo, prossima volta che si svende uno Stato al nemico pregasi avvisare prima, di modo da imparare meglio la lingua dei padroni… NB lascio volutamente alcuni termini non tradotti perché abbiamo ben presente che è a quei termini che si rivolge, è a quella, scomoda, impostazione che rivolge il suo attacco):
E oggi questo, dopo decenni di questa sostituzione (allude al discorso su pravda-istina e pravda-spravedlivost’, che peraltro cita qualche riga sopra N.d.T.) è quasi il compito più difficile: separare attentamente istina e spravedlivost’, trovare per ciascuna il proprio posto e fondamento. Alla prima, un’ informazione che sia precisa e completa; alla seconda, la struttura democratico-sociale. È importante comprendere come istina non obbedisca alle leggi di spravedlivost’, non sia dispensata secondo merito, non si allinei ai bisogni e nemmeno esprima pie intenzioni o desideri9.
Finita l’URSS, CERTE PAROLE FACEVANO ANCORA PAURA ALLA REAZIONE CHE AVEVA TRIONFATO SU TUTTA LA LINEA. Forse perché le parole che nascono con un certo DNA si possono dimenticare, non utilizzare, mai proibendole, semplicemente dichiarandole “obsolete” e seppellendole sotto tonnellate di altre parole, o neologismi, o termini stranieri… ma non si possono cambiare.
Peraltro, è abbastanza semplice individuare e smontare i meccanismi di questo discorso da neofita del liberal-liberista-libertario-pensiero occidentale. Li facevano e li fanno col copia-incolla: prima, nella fase di accusatio, confonde volutamente pravda (quella “partigiana”, per intenderci) con istina (quella che si vorrebbe “oggettiva”), quando forse è l’unica cosa che nessuno, neppure ai tempi della Pravda con la “P” maiuscola organo del PCUS, aveva mai messo in discussione; in altre parole, nessuno aveva mai messo in discussione che la “realtà oggettiva” fosse diversa dalla “giustizia”, ma esisteva quel termine che le univa, pravda, che ora cominciamo a capire perché sia scomodo, mentre “verità” non lo è affatto da quel punto di vista.
Pertanto, pravda delenda est! Ed ecco che subito dopo, dal suo discorso elimina del tutto la prima e amplifica fino a totalizzare la seconda laddove, invece, lo schema tradizionale vede istina come sottovoce di pravda, che contiene allo stesso tempo sia istina che spravedlivost’: comodo… una bella “verità” asettica, che ammette le ingiustizie, che se ne lava le mani… figli miei, io “rappresento” soltanto, poi se avete la forza e la voglia le ingiustizie ve le togliete, altrimenti… vuol dire che vi va bene così, anzi, vi dico già che vi va bene così… che è “giusto” così!
III. La Madre di Gorkij come caso esemplare di studio
Non era questa l’aria che si respirava nel lontano 1907: lontano cronologicamente e distante anni luce idealmente. Proprio in quell’anno Maksim Gorkij pubblicava uno dei suoi capolavori: Mat’ (La madre), che ben si presta per la nostra esplorazione. Per inciso, l’idea di ricercare proprio in questo romanzo un campo d’applicazione di questo e altri termini mi è venuta con ancora nella mente le parole della traduzione italiana! E se in una traduzione qualcosa si perde, si attenua, davvero possiamo intuire la grandezza di Gorkij nel tratteggiare questo personaggio, capace di travalicare anche i confini linguistici e di imprimere nel lettore, meglio, nella sua memoria, un segno indelebile al punto da fargli collegare il suo discorso su pravda, istina e spravedlivost’ a questa donna e al suo percorso.
La protagonista di questo romanzo, interpretata nella riduzione cinematografica del 192610 da Vera Baranovskaja,

è infatti una donna semplice, del popolo, che si trova però a esser madre di un giovane rivoluzionario: lo segue lungo le tappe del suo tormentato cammino, pur non comprendendo le sue scelte di vita, fino al triste epilogo del processo e della condanna.
Allo stesso tempo anche lei percorre il proprio cammino, dove cartina di tornasole è proprio quella verità (pravda) e, soprattutto, il riconoscimento graduale della stessa proprio nella vicenda del figlio e dei suoi compagni: iter, maturazione interiore che l’Autore descrive magistralmente, in un crescendo che porta la madre non solo all’approvazione della causa socialista, ma alla sua partecipazione alla militanza attiva.
La chiave di volta è, indubbiamente, il processo: è proprio qui che la pravda emerge in tutta la sua potenza, squarciando davanti ai suoi occhi il velo di ipocrisia dell’accusa e dei giudici. Ed è proprio su questo brano che, ai fini del nostro discorso, vale la pena soffermarsi:
“Ora a Vlasova (la madre, N.d.T.) era tutto più chiaro: perché aveva sperato nella giustizia (spravedlivost’), perché aveva pensato di assistere a un contenzioso serrato e onesto fra la verità (pravda) del figlio e la verità (pravda) di chi lo giudicava”11.
Notiamo come la madre, in questa fase di incertezza, consideri pravda un concetto da definire “tramite un contenzioso serrato e onesto” (строгую, честную тяжбу) e assolutamente non tramite un atto di fede, laica o religiosa a questo punto poco importa: è giusto sottolinearlo, in queste righe del processo farsa ai rivoluzionari che saranno di lì a poco deportati, si gioca praticamente tutto.
Un processo secondo pravda (prestiamo attenzione a quali parole contengono la stessa radice prav-) comportava, nelle aspettative della madre,
“che i giudici interrogassero Pavel (il figlio della Vlasova N.d.T.) a lungo, con attenzione e minuzia di particolari, scavando in tutta la sua vita, esteriore e interiore, guardando con occhio acuto tutti i pensieri e le azioni di suo figlio, tutti i suoi giorni. E, una volta vista la sua dirittura (pravota) allora, con giustizia (spravedlivo), avrebbero esclamato a gran voce: ‘Quest’uomo ha ragione! (prav, lett. “è giusto”)’. Ma nulla di simile era successo.”12.
Notiamo quindi come, in barba a qualsiasi postmodernismo, relativismo e, sostanzialmente, menefreghismo, pravda sia un processo anche nella sua individuazione, nella sua costruzione, fino al giudizio finale, punto esclamativo compreso: “Quest’uomo è giusto, ha ragione”! (Čelovek etot prav! Человек этот прав!).
Ancora, su questo punto, la madre esclama confusa mentre, a giochi ormai fatti, si attende solo il verdetto dei giudici: “Di chi è allora la verità (pravda)?” (чья же правда?)13. E ancor più disarmante la replica di uno degli imputati: “Perché qui si spremono, proprio, per la verità (pravda)…” (Da razve zdes’ o pravde tjagajutsja?… Да разве здесь о правде тягаются?..)
Infine, arriva la condanna: deportazione per tutti gli imputati; il potere zarista sembra ancora una volta avere la meglio, ma non è così: la madre, la tradizionalista madre, la prudente madre, ormai non ha più dubbi, su di chi sia la pravda:
“Così intendo voi tutti. Davvero (voistinu), siete tutti compagni, fratelli, figli della stessa madre: la verità (pravda)!14”
Quel voistinu, “davvero” nel senso di istina, “è così punto”, per i non russofoni, è uno dei massimi rafforzativi che questa meravigliosa lingua ci può offrire: giusto per dare un’idea, è il termine che apre la risposta all’augurio di “Buona Pasqua” “Christos voskrese!” (“Christus (re)surrexit!”), ovvero “Voistinu voskrese!” (“Vere resurrexit!”).
IV. Da pravda a partijnost’… il passo è breve, anzi immediato!
A questo punto è molto più facile, anche per noi che russi non siamo, capire il passaggio successivo, da pravda a partijnost’: la verità è espressione della visione di una parte, o di una visione di parte, prima ancora che di partito. È, per inciso, il passaggio chiave che collega anche pravda a realtà e quindi a realismo, da cui il realismo socialista, corrente letteraria egemone lungo tutta la parabola sovietica. Essere partigiani, vivere la propria partiticità (traduzione più autentica di partijnost’) è, anzitutto, un dovere. Lo diceva, peraltro, anche uno dei nostri, in un suo celeberrimo scritto del 1917 (grassetto mio, giusto perché poi le parole non vengono mai a caso…):
Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere partigiani”. Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. […] Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti15.
Torniamo però in Russia. Se tutto quanto premesso finora è innegabile, lo è anche il fatto che partiticità andasse sempre più a coincidere con l’obbligo di “fedeltà alla maglia”, meglio, al partito. Parliamo sempre di un partito che, dal 1905 alla fine della guerra civile seguita al Grande Ottobre, per 15 anni fu costantemente in pericolo, giorno dopo giorno, in un Paese dove il “conflitto di classe” era vissuto nella sua visione più estrema, ovvero repressione, clandestinità, guerra. E quando si è costantemente sotto il tiro dei pezzi d’artiglieria nemici è difficile maturare posizioni che non siano altrettanto estreme e non richiedessero atti di partigianeria molto più radicali di quanto accadeva, per esempio, in Occidente.
Mantenere, tuttavia, questa posizione in tempo di pace, insieme a un progressivo rifiuto di qualsiasi dialettica interna franca, aperta, polemica anche ma sincera, perché frutto di dissenso fra parti comunemente orientate verso un unico fine, portò tale movimento alla sua, inevitabile, burocratizzazione, imbalsamazione entro una cornice di fedeltà “alleluiante”.16, acritica al potere costituito e alle sue logiche, ai suoi meccanismi, di cui si era – di fatto – parte integrante.
Ecco come questa partijnost’ ridotta a semplice, formale, disciplina di partito, a cinghia di trasmissione ingessata e ruffiana si separò progressivamente da quella pravda che aveva infiammato i cuori dei rivoluzionari russi di allora. Tornando all’aforisma di qualche pagina fa, nella Pravda (giornale) c’era sicuramente partijnost’, ma sempre meno pravda. A rimetterci, fu l’istituzione stessa sindacale, che perse progressivamente credibilità agli occhi dei lavoratori.
Questo accadeva in un URSS dove, con tutti i difetti, la proprietà sociale dei mezzi di produzione e la conduzione pianificata degli stessi aveva reso impossibile, per oltre mezzo secolo, la nascita di ingiustizie che non fossero confinate al puro campo etico e morale. […]
Note
1 A. Ernout e A. Meillet, Dictionnaire Étimologique de la Langue Latine, Paris, Klincksieck, 2001, p. 727.
2 Max Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1950-8, ed. russa Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. (с доп.), Moskva, Progress, 1986, Vol. I, pp. 292-293.
3 Giovanni Semerano, Le origini della cultura europea. Dizionario della lingua latina e di voci moderne, Vol. II, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1994, p. 610.
4 Max Vasmer, Op. Cit., Vol. III, p. 352
5 Mary Douglas, Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Bologna, il Mulino, 1975-1993 -2014.
6 Max Vasmer, Op. Cit., Vol. II , p. 144.
7 «Всякий раз, как мне приходит в голову слово «правда», я не могу не восхищаться его поразительною внутреннею красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда, в этом огромном смысле слова, всегда составляла цель моих исканий». Nikolaj Konstantinovič Michajlovskij, Opere (Сочинения), IV ed., Sankt Peterburg, Russkoe Bogatsvo, 1906, Vol. I, Prefazione alla III edizione, p. VI.
9 И теперь, после десятилетий подмены, едва ли не труднейшая задача – тщательно разделить истину и справедливость, найти для каждой свое место и основание. Для истины – в точной и полной информации, для справедливости – в демократическом общественном строе. Важно понять, что истина не подчиняется законам справедливости, не раздается по заслугам, не выравнивается по потребностям, и даже не выражает ничьих благих намерений и пожеланий. Michail Epstein, “Dalla pravda alla istina” (От правды к истине, gennaio 1992) fonte
10 Vsevolod Pudovkin, Mat’, URSS, 1926.
11 Теперь Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидать строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судей его. Maksim Gorkij, Mat’, Moskva, Detskaja literatura, p. 259 Ed. italiana, Massimo Gorki, La madre, Milano, BUR, 1956, p. 332.
12 Что судьи будут спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни его сердца, они рассмотрят зоркими глазами все думы и дела сына ее, все дни его. И когда увидят они правоту его, то справедливо, громко скажут: — Человек этот прав! Но ничего подобного не было. Ibidem.
13 Ibidem, p. 267.
14 Воистину, все вы — товарищи, все — родные, все — дети одной матери — правды! Ibidem, p. 280.
15 Antonio Gramsci, “Indifferenti”, La città futura, numero unico, 1917, reperibile integralmente in rete all’indirizzo marxists.org
16 La guerra era stata vinta, ma i suoi esiti e le sue lezioni continuavano a restare sotto gli occhi di Stalin. Nel 1946, intervenendo a un incontro con gli intellettuali degli ambiti creativi, Stalin parlò degli esiti della guerra appena trascorsa: “A salvare l’umanità sono stati semplici cittadini sovietici i quali, senza far polemiche o montar su teatrini, nelle condizioni più difficili che potevano incontrare, dopo aver già compiuto l’industrializzazione, collettivizzato e rafforzato radicalmente la capacità difensiva del Paese, a prezzo della loro vita e con a capo i comunisti, sbaragliarono infine il nemico. A proposito, solo nei primi sei mesi di guerra abbiamo perso in battaglia cinquecentomila comunisti e, in tutta la guerra, oltre tre milioni. Erano i migliori dei nostri, combattenti per il socialismo e per la felicità del popolo, di spirito nobile, cristallino, pulito, altruista e disinteressato. Oggi ci mancano… se fossero ancora vivi, molti nostri problemi di oggi sarebbero già stati superati”.
“Se fossero ancora vivi…” La loro assenza aveva portato Stalin a conclusioni angoscianti. Analizzando gli esiti della guerra trascorsa, in una cerchia ristretta di membri del politburo, Stalin disse, nella sorpresa generale: “La guerra ha dimostrato che, nel Paese, non c’erano poi tutti quei nemici interni che abbiamo denunciato e preso di mira. Molti hanno sofferto invano. Il popolo dovrebbe mandarci via per questo. A calci in culo. Occorre confessare”.
A rompere il silenzio generale fu mio padre:
– Noi, nonostante, lo statuto, è da tanto che non convochiamo il congresso del partito. Occorre farlo e discutere i problemi del nostro sviluppo, della nostra storia.
Venne in appoggio a mio padre N. A. Voznesenskij. Tutti gli altri stettero muti. Stalin fece segno di lasciar perdere.
– Il partito… partito cosa… guarda cosa è diventato, un coro di salmodianti, una truppa di alleluianti… è necessaria una profonda analisi preliminare.
Jurij Andreevič Ždanov, Uno sguardo al passato: memorie di un testimone (Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца), Rostov na Don, Feniks, 2004, pp. 226-7.
17 Vedasi, a puro titolo introduttivo, la definizione didascalica di “principio di partiticità” (党性原则 dǎngxìngyuánzé) nell’equivalente cinese di wikipedia fonte
