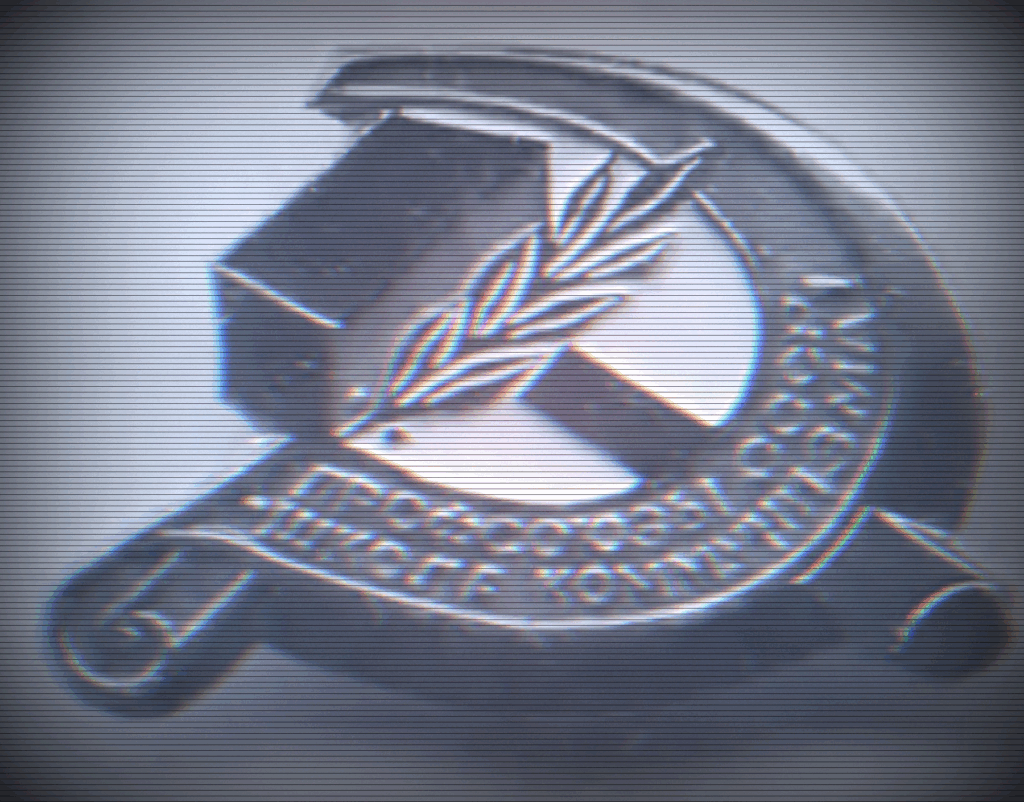
Di Paolo Selmi per SinistraInRete.info
La domenica di sangue e la sconfitta militare contro i giapponesi contribuirono al crollo verticale di credibilità del regime zarista, da un lato, e all’aumento contestuale della stessa su quel versante opposto di recente formazione (perché allora, a differenza di oggi, c’era un “versante opposto”).
Dal punto di vista sindacale, notiamo che la sempre maggiore differenziazione non teorica (dal momento che anzi, al contrario, scioperi alimentavano manifestazioni e manifestazioni alimentavano scioperi), ma operativa fra istanze politiche, rappresentate dal POSDR, e istanze economiche rappresentate sino ad allora “in supplenza” dallo stesso POSDR, rese finalmente necessaria la creazione di un’istituzione sociale a esse preposta, il sindacato ovvero, alla russa: l’unione (sojuz) operaia (rabočij) delle professioni (professional’nyj, che nell’inversione di ordine fra aggettivi e sostantivo è профессиональный рабочий союз), da cui l’abbreviazione profsojuz1.
Unioni di tipo sindacale erano già comparse a Pietroburgo fra le fila del movimento collaborazionistico del pope Gapon, ma dalla domenica di sangue del 1905 in poi persero qualsiasi valenza e lasciarono il campo alle prime, vere, formazioni sindacali. Entro l’estate di quell’anno, a Pietroburgo, erano stati fondati già 7 sindacati di categoria, di cui solo due erano legali mentre gli altri agivano in regime di semi-clandestinità. Il resto del Paese, invece, era ancora praticamente escluso da questo fiorire sindacale.
Fu tuttavia con la fallita Rivoluzione del 1905 che il movimento sindacale conobbe il proprio battesimo del fuoco, da un lato, e un sempre maggiore riconoscimento a livello nazionale a livello di rappresentanza dei lavoratori e di organizzazione di massa degli stessi. Se dal lato più politico vi erano i soviet (совет), dall’altro più economico vi erano i profsojuz. A ottobre erano già 44 i sindacati di categoria a Pietroburgo e 50 a Mosca, in un crescendo che coinvolgeva ormai tutti i centri industriali dell’Impero. Questa nuova forma di autoorganizzazione operaia mostrava tutta la sua maturità nel dotarsi di Statuti, strutture direttive e di controllo, divisioni dei compiti e delle mansioni, e tutto quanto servisse a rendere agile ed efficace la crescita del neonato organismo sociale.
Fu in tale cornice che, sempre nello stesso periodo (27 ottobre a Mosca, 6 novembre a Pietroburgo), nacque in ogni città un “Ufficio centrale delle unioni sindacali” (центральное бюро союзов), grosso modo l’equivalente della nostra Camera del Lavoro, col compito di coordinare le attività sindacali delle diverse categorie. La reazione successiva al soffocamento del tentativo rivoluzionario indebolì notevolmente, ma non riuscì a scardinare del tutto il lavoro di quei mesi.
In altre parole, il governo zarista fu costretto a riconoscere legalmente la figura dei profsojuz, elaborando un apposito disegno di legge che andò a coincidere, dal 24 febbraio 1906, con la Seconda conferenza panrussa dei sindacati (вторая всероссийская конференция профессиональных союзов): la “prima” si era persa per strada a ottobre dell’anno precedente, ma vollero tenerla come riferimento e partirono a numerare dalla seconda2.
Oggetto principale della discussione di tale assemblea fu proprio la legge sui sindacati. La domanda era semplice: aveva senso sottostare a una legge così restrittiva? Tale da impedire la nascita di confederazioni sindacali e di qualsiasi camera del lavoro (o ufficio centrale di collegamento intercategoriale), da dare alle amministrazioni locali la possibilità di scioglierli in qualsiasi momento, da dare alle stesse amministrazioni il potere di ratifica dei suoi organi direttivi, da limitare il loro ambito funzionale al “chiarimento e all’armonizzazione fra interessi economici e miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri membri”3?
Su tale questione si scontrarono destra e sinistra del movimento sindacale (in cui si riflettevano le divergenze fra menscevichi e bolscevichi). La risoluzione finale espresse una sintesi fra entrambe le posizioni: accettare formalmente la legge, che sarebbe divenuta tale il 4 marzo 1906, quindi iscriversi, registrarsi, comunicare alle autorità nomi e organigrammi ma, al contempo, continuare a sviluppare appieno la propria attività, anche – e soprattutto – dove la legge lo proibiva. Fu così che i profsojuz da un lato ottennero il loro primo, ufficiale, riconoscimento giuridico e, dall’altro, poterono continuare a espandere la propria attività, creando centri di coordinamento provinciali, regionali e nazionali (contro la legge), a volte nella piena illegalità, a volte sotto le mentite spoglie di centri culturali. Si calcola che fra il 1905 e il 1907, fra organizzazioni legali e illegali, esistessero circa 800-900 sezioni sindacali con 250-300.000 iscritti, al netto di 250 sezioni sciolte dalle autorità zariste4.
Fulcro dell’attività sindacale di quel periodo fu la lotta economica. Nel 1905 le rivendicazioni sindacali vertettero essenzialmente sulla riduzione dell’orario di lavoro, con una campagna di scioperi che portò buoni risultati in tale senso. Ciò rese possibile, nel 1906, occuparsi anche degli aumenti salariali, di eliminazione del cottimo (сдельщина) e del lavoro straordinario (сверхурочная работа), oltre che porsi sempre più, di fronte al padronato, come unico interlocutore per tali questioni. Restava sempre parte integrante delle sue attività il mutuo soccorso dato dall’assistenza economica, legale e sanitaria fornita agli iscritti: iscritti e quadri che, vale la pena sottolinearlo, potevano avere o non avere la tessera del POSDR (e a non averla erano in molti).
Anche il padronato, tuttavia, cominciava allora a costituirsi in organizzazione confindustriale e, a fronte degli scioperi, a rispondere con altrettante serrate. Repressione poliziesca e padronale, congiuntamente, smorzarono l’ondata rivoluzionaria del 1905 sfoltendo negli anni successivi i numeri di scioperi e di scioperanti: dai 5.780 scioperi del 1905 ai 973 del 1907, dai 1.439.000 scioperanti ai 200.000 di due anni dopo5. Nulla fu regalato, nulla fu mai semplice per i profsojuz.
Dal punto di vista dei rapporti col POSDR, i profsojuz furono oggetto delle sue attenzioni sin da prima della sua esistenza, anzi, sin da prima dell’esistenza dello stesso POSDR. Negli anni Novanta si potevano già individuare due tendenze: da un lato, gli “economicisti”, facenti capo politicamente al revisionismo bernsteiniano, che sostenevano che un sindacato (peraltro allora inesistente…) dovesse fare il sindacato e basta, senza immischiarsi con la politica: anzi, come vedremo qui sotto, la lotta sindacale ristretta a rivendicazioni puramente economiche diveniva un pretesto per declinare l’intero discorso, economico e soprattutto politico, all’interno di un orizzonte strettamente riformistico; dall’altro, i militanti facenti riferimento al giornale Iskra (La scintilla) che, con Lenin in testa, ne intuivano il potenziale all’interno di un discorso rivoluzionario più complesso e articolato, in riferimento a una concezione di partito altrettanto rivoluzionaria, il cui nucleo (ядра) sarebbe dovuto essere composto interamente da rivoluzionari di professione (революционеры – профессионалы).
La questione fu posta con chiarezza da Lenin una decina di anni più tardi. Nel suo scritto del 1902 “Che fare?” (Что делать?), collegandola ad altri elementi del ragionamento economicistico, ribalta un’affermazione, apparentemente neutra e ragionevole, di uno fra i massimi esponenti dell’economismo di allora: Aleksandr Samojlovič Martynov (1865-1935), apparsa sulle colonne della loro testata il Rabočee Delo (Рабочее Дело, “La causa operaia”). Il grassetto è mio:
Così, dietro alla frase pomposa: “conferire alla stessa lotta economica un carattere politico”, che suona “spaventosa”, dal significato profondo e rivoluzionaria, si nasconde, in sostanza, la tendenza tradizionale a ridurre la politica socialdemocratica a politica tradunionista!6
Economismo era diventato sinonimo di menscevismo, in opposizione al bolscevismo leniniano che, cinque anni più tardi, avrebbe precisato nell’introduzione a una sua prima raccolta di scritti del 1907 la propria concezione di “neutralità” del sindacato. Il sindacato, che allora non era più un’ipotesi, ma una realtà fattuale, poteva e doveva lavorare autonomamente entro il proprio ambito, ma la propria neutralità non poteva assolutamente costituire un principio assoluto, proprio perché non ci si poteva permettere il lusso di perdere di vista l’obbiettivo di fondo, dato dall’unità di intenti fra azione politica e azione economica: unità di intenti che, a differenza della visione riformistica, non doveva essere cercata riducendo l’orizzonte politico al tradunionismo, ma elevando al contrario l’azione sindacale affinché potesse inquadrare la propria azione entro nuove, più ampie, prospettive. Questo, senza pretendere di cambiare tutto dall’oggi al domani, senza procedere a sbrigative rese dei conti ed epurazioni, ma impiegando tutti i mezzi e la necessaria, non meno rivoluzionaria, pazienza:
Dobbiamo prestare attenzione anche alla questione della lotta economica e dei sindacati. Mi capita spesso di leggere critiche nei miei confronti per posizioni sull’argomento che non ho mai avuto. È a questo punto necessario che sottolinei come, già in “Che fare?”, abbia dedicato molte pagine a chiarire l’enorme significato da me attribuito alla lotta economica e ai sindacati. In particolare, allora avevo affermato la neutralità (нейтральность) dei sindacati.
Da quel momento non ho mai detto altro, né negli opuscoli, né nelle pubblicazioni sui giornali, nonostante quanto possano affermare i miei oppositori. Tuttavia, a partire dal Congresso di Londra del POSDR e dal Congresso internazionale socialista di Stoccarda, sono giunto alla conclusione che non possa esistere una neutralità sindacale fine a sé stessa (принципиально).
Se vogliamo esprimerci in questi termini, l’unico vero principio da applicare deve essere quello di allineare sempre più la linea sindacale a quella del partito. Sforzarsi di avvicinare e collegare il sindacato al partito: questa deve essere la nostra politica, da perseguire necessariamente con costanza e perseveranza in tutta la nostra propaganda, nella nostra agitazione, nelle nostre attività organizzate, senza puntare al semplice “riconoscimento” e senza cacciare dal sindacato chi sia di altro parere7.
Ancora una volta sulle “origini” (in riferimento alle due maggiori esperienze del movimento operaio mondiale)
Quanto appena riportato ci porta ad apprezzare, ancora una volta, la grandezza di una figura storica come Lenin, la sua capacità di leggere la situazione, di comprendere cosa fosse meglio fare con quanto a disposizione in quel momento, di rivedere, se necessario, le proprie posizioni alla luce dei mutamenti in corso. Certo. Tuttavia, ci porta anche a svolgere alcune considerazioni sull’esperienza storica dei rivoluzionari russi prima e sovietici poi, diversa dalla nostra, per esempio, e diversa da quella cinese, per altri versi. In questo paragrafo tratteremo a grandi linee di quest’ultima, perché utile “limite di un campo di esistenza”, socialmente e storicamente determinato, entro cui collocare le varie esperienze storiche oggetto di studio tra cui, ça va sans dire, anche quella russa prima e sovietica poi. E apprezzare in ultima analisi come tale posizione, storicamente e socialmente determinata, sia MOLTO più vicina alla nostra di quanto qualche “purista”, di quelli che da Marx “saltano la siepe sovietica” e arrivano dritti ai giorni nostri (e viceversa! Da oggi al Capitale senza considerare minimamente quell’esperienza), ancor oggi ritenga.
La storia ha tempi lunghi, anzi, lunghissimi e tempi corti, anzi, cortissimi. Fin qui ho scritto un’ovvietà. Meno ovvio è, invece, il fatto che un dato fenomeno in un dato tempo e luogo si riproduca storicamente in una data società con modalità e velocità sostanzialmente – a volte radicalmente! – diverse rispetto ad altre analoghe situazioni.
Questo non significa assolutamente legittimare certe attuali posizioni, cerchiobottistiche e opportunistiche, che vedono rosso dove rosso non c’è, ovvero che trovano quello che vogliono cercare e dicono di averlo trovato, e lo lodano a gran voce, anche qualcuno gli fa notare… che il re è nudo, pur “con caratteristiche cinesi”.
No, non è questo il passaggio conclusivo dell’osservazione appena segnalata in grassetto. Quanto segue, pertanto, costituisce a mio avviso un momento fondamentale in questa analisi del movimento sindacale e operaio russo. Vale quindi la pena ritornarci, tornando all’Occidente, e relativa storia, alla Russia, con la sua e alla Cina con la propria.
CASO EUROPEO: c’è poco da dire. Un mondo, quello delle potenze industriali europee, primo per spola che batte avanti e indietro fra gli sbuffi del vapore, primo per formazione di una classe operaia così come la intendiamo nel modo capitalistico di produzione, primo anche per lo studio, e critica, di tale modo capitalistico, primo per l’elaborazione di una «filosofia della praxis» per uscire dallo stesso e non per tornare indietro, ma per andare avanti, non a caso… “Avanti!”.
PRIMO A COSTRUIRE UN MODELLO, SMONTARLO, RIMONTARLO LUNGO DUE INTERNAZIONALI E NON SOLO: guardando al passato, parliamo di un modello che non nasce calato dal nulla, ma che è frutto, di fatto, di una strada di emancipazione di secoli, lo si ricordava anche nella prima parte di questo lavoro; un modello che si basa quindi su tale percorso e sul suo vissuto, oltre che sulla composizione e le dinamiche dei rapporti di classe allora esistenti. Guardando al futuro, un modello che in quegli anni era peraltro in già pieno sviluppo rispetto a Tesi, quelle della Seconda Internazionale, criticate dalle punte più avanzate del movimento, come revisionistiche.
CASO RUSSO: l’avanguardia rivoluzionaria russa, e il movimento sindacale a essa connesso, pur nei dovuti distinguo di grado di sviluppo delle forze produttive e sociali e dei relativi rapporti fra esse intercorrenti
– SI CONFRONTA CON TALE MODELLO E CERCA DI RIPRODURLO, kak umèli i kak moglì (“come sapevano e come potevano”), come ci siam detti qualche pagina fa.
Non erano, TUTTAVIA, cronache marziane, erano già “marxiane” e senza apparire di un altro pianeta. Certo, i contesti erano diversi, ma Russia zarista ed Europa occidentale costituivano, per intendersi, due sponde dello stesso tavolo da biliardo. La palla rimbalzava dall’Europa occidentale e arrivava in Russia attraverso il linguaggio comune già parlato da entrambe. Da parte della classe dirigente russa, secoli di corrispondenza epistolare, letteratura, idee politiche (ivi comprese quelle rivoluzionarie), diplomazia in francese, di basi umanistiche in greco e in latino e, più recentemente, di modernizzazione tecnologica in tedesco: la Russia zarista sapeva bene cosa c’era “dall’altra parte”.
E l’avanguardia politica rivoluzionaria? I sindacati? Il modello, sostanzialmente, è analogo: i rivoluzionari russi leggono, viaggiano, scambiano idee, sono egualmente al corrente di quanto accade “dall’altra parte”. “Un’altra parte” che, tuttavia, non si differenziava ormai tanto per il segno della croce fatto all’incontrario, grosso modo dal secolo XIII in avanti, o per l’iconoclastia, o “mancanza di rispetto” dei figli nei confronti dei padri, ma dal punto di vista di sviluppo delle forze produttive e materiali, oltre che dei rapporti di produzione a essi connessi: in quello, era divenuto un altro mondo rispetto alla realtà russa. E per parlare, alla realtà russa, tale modello non poteva essere traslato così, meccanicamente.
Ecco allora il cercare di “adattare” QUEL MODELLO alla REALTÀ RUSSA. Lo si fa comprimendo modi e tempi, riducendo alcune fasi ed espandendone altre all’interno di un processo complessivo COMUNQUE di ACCELERAZIONE, BRUCIANDO LE TAPPE, SEMPLIFICANDO, SFRONDANDO, andando poco per il sottile su passaggi che, “a matrice”, recavano un ordito sicuramente diverso e più complesso, articolato, eccetera.
Tutto questo, DOVENDOLO fare per allineare il movimento rivoluzionario locale, e relative istanze, a quello internazionale. Tutto questo, repetita juvant, POTENDOLO fare perché la Russia zarista, di fatto e nonostante il “Grattez-le-Russe-et-vous-trouverez-le-Tartare” prevalente già da allora nel blocco di potere centro-europeo, ERA Europa: e il problema, più che di traduzione, era sostanzialmente di interpretazione e di svolgimento in condizioni di riproduzione diverse dal modello di riferimento. In altre parole, tra-sferimento (e adattamento, critica, ri-elaborazione, ri-creazione, sviluppo fino alla finale, leninistica, INNOVAZIONE), ma non tra-duzione.
CASO CINESE: i rivoluzionari cinesi a inizio XX secolo, allora studenti fuori sede nelle Università giapponesi, vero ponte “modernizzazione” e “arretratezza” acquisiscono da zero “un pacchetto completo”, tra-dotto in blocco e non più tardi di due decenni prima dall’avanguardia rivoluzionaria giapponese. Per i non addetti ai lavori, si trattava di un unicum storico senza precedenti, in quanto per secoli il movimento era stato esattamente l’inverso, dalla Cina al Giappone. A partire dal fatto che i giapponesi avevano imparato dai cinesi la scrittura, acquisendo con i kanji o hanzi 漢字, “segni degli han” e in un colpo solo un altro, ENORME, “pacchetto completo”: confucianesimo e le altre “novantanove scuole” restanti, taoismo, buddhismo (di tutte le scuole dalla cosiddetta mahayana alla dhyāna) e, con essi, decine di migliaia di neologismi (prestiti linguistici). Per questo tutt’oggi i nipponici trascrivono la loro lingua, che col cinese non c’entra nulla, ogni volta che una parola oltre ad avere un significante ha un significato, in segni cinesi .
Per questa loro facilità di introiettare idee estere (cinesi, allora, occidentali, secoli dopo), i giapponesi da retroguardia che riceveva e introiettava i classici cinesi nella propria cultura, divennero avanguardia nel ricevere e introiettare ALTRI CLASSICI, stavolta occidentali. Questo, per inciso, al netto di tutta l’arbitrarietà di tale processo di ASSOCIAZIONE di segni e significati provenienti da contesti totalmente estranei fra loro. Finché da cum-panis o camarade nello stesso stanzone, si diventa in azero e turco yoldaş, “compagno di strada” (da yol, strada), che poi richiama lo stesso spirito carovaniero che accompagna l’equivalente russo tovarišč товарищ, e si sbarca in Estremo Oriente come dōshi, o tongzhi, 同志, “stessa volontà”, rimando alle triadi e alle società segrete fioccate in quei secoli (heishoudang 黑手黨, “partito della mano nera”, mafia), poco male. Diviene un po’ più problematico tradurre concetti come “socialismo”, shakaishugi 社会主義… avendo appena tradotto, e non senza contraddizioni, il concetto di “società”, shakai 社会8!
Com’è come non è, “non è tempo di spaccare il capello in quattro”, pensarono i rivoluzionari d’Estremo Oriente. E se non lo spaccarono i giapponesi, men che meno lo fecero i cinesi! Anzi, TUTTO IL LAVORO SVOLTO DAI RIVOLUZIONARI GIAPPONESI tornò utile ai rivoluzionari cinesi di fine Ottocento, studenti fuori sede in Giappone e con fame di rivoluzione: la scrittura giapponese aveva INFATTI pre-digerito per loro UN IMMENSO PATRIMONIO, QUELLO OCCIDENTALE, usando gli stessi “segni cinesi” che loro stessi per secoli gli avevano passato, nozioni nuove, “moderne”, i cui originali erano codificati in segni per loro illeggibili.
Ecco come i cinesi riuscirono a tradurre, dal giapponese e in un colpo solo, il Manifesto e manuali marxisti in cinese:
– trovando metà del lavoro già fatto (i kanji 漢字) e
– cambiando essenzialmente la sintassi del periodo (cinese: S+V+O, giapponese: S+O+V come le lingue di ceppo uralo-altaico che costituiscono una delle sue due matrici) e
– trasformando le parti del discorso espresse negli alfabeti FONETICI autoctoni (hiragana ひらがなe katakana カタカナ) rispettivamente in particelle grammaticali cinesi (Vした/ た → V了)e in segni ritenuti convenzionalmente “neutri”, ovvero neutralizzati del proprio significato mantenendo il solo significante E CREANDO, DI FATTO, UN “ALFABETO FONETICO” PER I NOMI STRANIERI(Città Roma → ロマ “RO-MA”, giapponese, alfabeto FONETICO “katakana”, significanti senza significato, da sempre usato per i nomi “stranieri” → 羅馬, cinese, Luo Ma, che non vuol dire “rete per catturare uccelli”-“cavallo”, ma perde ogni significato andando solo di significante, Luoma, per l’appunto).
Un conto è scaricare da internet un manuale di chitarra jazz, e un conto è capire una scala dorica. Un altro ancora, suonare come Joe Pass… La velocità di traduzione, purtroppo, fu direttamente proporzionale al caos traduttologico e, di converso, al disordine ideologico conseguente. Un immenso patrimonio di lotte, critiche, analisi, strategie, ideali fu così INEVITABILMENTE acquisito in maniera del tutto acritica: una nebulosa asincrona, una “raccolta di grandi successi” acquisita “in quanto tale”, con “tracce musicali di qualche minuto” accostate acriticamente se non per essere identificabili, a grandi linee, con tale nebulosa, comprendenti peraltro generi completamente diversi fra loro… e a prevalenza anarcosindacalistica (era la “moda” pre-sovietica nel Vecchio Continente frequentato dai giapponesi e, in seconda, dai cinesi… non era un caso se in Giappone, e quindi in Cina, Kropotkin prima del trionfo dei Soviet era più popolare di Marx).
Ancora peggio, quando tali assunti e costrutti ideologici, tale “macedonia” di “grandi successi” scoordinati fra loro, frutto di secoli di lotte altrove (un “altrove” che però era il cosiddetto PROGRESSO), si cercò di incastrarli nel proprio contesto, culturalmente, socialmente, economicamente estraneo agli stessi, oltre che a stragrande maggioranza contadino e semifeudale. Questa è la realtà dei fatti. Ci ho scritto per quattro anni una tesi di Dottorato in ricerca di 500 pagine9 e non mi dilungo ulteriormente.
Ne accenno, in questa sede, soltanto perché ci aiuta a meglio collocare la situazione della Russia zarista e del suo movimento sindacale e rivoluzionario: porla, in questo senso, tra Occidente ed Estremo Oriente ci aiuta a capire la difficoltà oggettiva – insieme alla necessità, altrettanto oggettiva – di alcuni passaggi, altrimenti facilmente equivocabili come “estranei all’ortodossia” da parte di alcuni “puristi” e benpensanti nostrani. Se è vero, infatti, che la Russia è Europa, nel senso sopra descritto, esistono alcune peculiarità, specificità che vale la pena sottolineare, perché direttamente incidenti sul processo rivoluzionario in corso in quegli anni. Quanto segue è un breve cenno a un percorso di analisi a mio avviso del tutto proficuo, in tal senso, e non solo per la realtà russo-sovietica.
Note:
